Leggende ardennesi
Suggestione ed immaginario in quel di Ardenno

Ardenno
Scrive Massimo Bormetti, a conclusione della sua bella monografia “Al tempo delle streghe” (Bissoni,  Sondrio, 1963 I): “La prima condanna a morte di una strega la si ebbe nel 1275 in Francia, l'ultima nel 1775 in Germania. Queste due date riguardano però due fatti estremi ed isolati. In realtà l'inizio della persecuzione contro la stregoneria, su vasta scala la si deve fissare verso il secolo XV e la fine verso il secolo XVIII. Durò quindi circa quattro secoli. Come abbia potuto persistere così a lungo, è inspiegabile.
Sondrio, 1963 I): “La prima condanna a morte di una strega la si ebbe nel 1275 in Francia, l'ultima nel 1775 in Germania. Queste due date riguardano però due fatti estremi ed isolati. In realtà l'inizio della persecuzione contro la stregoneria, su vasta scala la si deve fissare verso il secolo XV e la fine verso il secolo XVIII. Durò quindi circa quattro secoli. Come abbia potuto persistere così a lungo, è inspiegabile.
Possibile che nessun governo, nessuna autorità, nessuno dei tanti esponenti della giustizia, nonostante le pur molte opposizioni da parte di scrittori, di scienziati ed anche di alcuni buoni giudici, non si siano mai accorti della totale infondatezza di quelle accuse e siano stati necessari proprio tre secoli di orrori per vederci chiaro? Non è facile dire come questo sia potuto accadere. Forse una spiegazione c'è: la stregoneria è sorta in un periodo di guerre durato. quasi senza interruzione, dal 1337 al 1648, durante il  quale sono state combattute la guerra dei cento anni. quelle di Carlo V e di Filippo II, le guerre di religione e, infine, quella dei Trent'anni, che coinvolse pressoché tutta l'Europa. Probabile che dopo il primo mezzo secolo di ostilità, e cioè verso il 1400, quando appunto in dipendenza della guerra, l'impoverimento delle popolazioni era già inoltrato, l'istruzione fosse diventata piuttosto scadente anche negli alti ranghi della giustizia, per cui i giudici di valore andavano sempre più diradandosi per lasciare sempre più numerosi posti a giudici incapaci.
quale sono state combattute la guerra dei cento anni. quelle di Carlo V e di Filippo II, le guerre di religione e, infine, quella dei Trent'anni, che coinvolse pressoché tutta l'Europa. Probabile che dopo il primo mezzo secolo di ostilità, e cioè verso il 1400, quando appunto in dipendenza della guerra, l'impoverimento delle popolazioni era già inoltrato, l'istruzione fosse diventata piuttosto scadente anche negli alti ranghi della giustizia, per cui i giudici di valore andavano sempre più diradandosi per lasciare sempre più numerosi posti a giudici incapaci.
E l'incapacità non doveva essere limitata al solo campo della giustizia, ma estesa a tutti i livelli. Infatti, anche i medici che furono interpellati per sapere se le malattie, le morti capitate alle persone erano dovute a mali naturali o a malefici, non seppero affermare francamente e senza titubanze che si trattava di mali naturali, sempre verificatisi anche in passato, quando nessun sospetto vi poteva essere contro le streghe. Quegli stessi parroci che, certo a fine di bene, e a richiesta degli interessati, abbondarono in benedizioni  ai maleficiati conl'asserito intento di liberarli da immaginari spiriti maligni e guarirli così dal maleficio, non seppero rendersi conto che, con cotale loro operato, mettevano in pessima vista gli accusati, sia di fronteai giudici che all'opinione pubblica, e davano inoltre un vigoroso contributo al perpetuarsi delle deleterie superstizioni del loro tempo.
ai maleficiati conl'asserito intento di liberarli da immaginari spiriti maligni e guarirli così dal maleficio, non seppero rendersi conto che, con cotale loro operato, mettevano in pessima vista gli accusati, sia di fronteai giudici che all'opinione pubblica, e davano inoltre un vigoroso contributo al perpetuarsi delle deleterie superstizioni del loro tempo.
Tutto questo non giustifica, ma spiega un poco, la persistenza della stregoneria. Questa poi cessò dopo mezzo secolo di pace, quando le popolazioni, riavutesi dalle batoste delle guerre, avevano ripreso un certo benessere ed un migliore grado di istruzione, tanto che non si trovava ormai più né un giudice, né un podestà, né un reggente d'istruzione tanto scadente da essere disposto ad imbastire nuove procedure contro le streghe. La prima nazione a togliere dai propri ordinamenti giudiziari l'obbrobrio dei processi alle streghe fu l'Olanda, seguita qualche lustro dopo dal Canton di Ginevra, dalla Svezia e dall'Inghilterra, e poi, a breve distanza, da tutte le altre nazioni.
Resta da chiarire come mai processi. per stregoneria siano tutti eguali, sia nelle domande dei giudici che nelle risposte degli accusati, sia nei delitti confessati, come nei mezzi per attuarli… in tutti i processi di stregoneria, ovunque tenuti, si ebbe una pressoché perfetta uniformità d'interrogatori, di ammissioni di malefici, di partecipazioni a balli diabolici, di rinnegamento di fede, di passaggi agli ordini del diavolo e di delitti mai commessi… Si tratta … di decine di milioni di delitti totalmente fantastici, assurdi, mai da nessuno accertati, confessati per veri, e che trasformarono due milioni di innocenti in altrettanti «rei confessi» come venivano designati quei disgraziati, e che furono oggetto di condanne al bando per alcuni e a morte per i più, e per tutti alla confisca dei beni. Tale fu la funesta vastità di quel dramma.”

Prati a Piazzalunga
Due milioni di innocenti, annota il Bormetti: una cifra che, per quanto congetturale, lascia allibiti, agghiacciati. Il
Seicento fu, sotto questo profilo, in Valtellina e Valchiavenna, come nel resto d'Europa, il secolo più nero:
infierirono sulle popolazioni valligiane crudeltà e devastazioni
causate dagli eserciti contrapposti nella guerra dei Trent’anni,
e poi, dal 1629, la peste, altro terribile portato di questa infausta
guerra, ed infine le conseguenti carestie, che determinarono un vasto
movimento emigratorio.
Paura e frustrazione favorirono una forte recrudescenza di quella caccia
alle streghe che già era iniziata, in forme più blande,
nei secoli precedenti. Quando il male attanaglia una popolazione, cresce
l’esigenza di trovare dei colpevoli, di dare un volto a questo
male, un volto invisibile ed uno visibile. Il volto invisibile è
presto trovato: le potenze del male, i demòni, il diavolo. Quello
visibile è meno ovvio, meno scontato, ed assunse i tratti di
qualche sguardo un po’ sbieco, un po’ troppo spiritato,
di qualche figura di donna scarmigliata, eccentrica, singolare, delirante
(nel senso etimologico di “fuori dal solco”, “fuori
dalle righe”). La strega, appunto, spesso povera mentecatta che  confessava anche spontaneamente convegni con il diavolo, malefici, fatture,
infanticidi, diffusione di malattie che colpivano raccolti, bestie ed
anche uomini, insomma opere diaboliche frutto della sua patologica fantasia.
Poi,
nel Settecento, il fenomeno dei processi (e delle orribili torture connesse:
a quei tempi si considerava credibile una confessione estorta fra gli
spasimi del dolore) e delle condanne a morte si diradò.
confessava anche spontaneamente convegni con il diavolo, malefici, fatture,
infanticidi, diffusione di malattie che colpivano raccolti, bestie ed
anche uomini, insomma opere diaboliche frutto della sua patologica fantasia.
Poi,
nel Settecento, il fenomeno dei processi (e delle orribili torture connesse:
a quei tempi si considerava credibile una confessione estorta fra gli
spasimi del dolore) e delle condanne a morte si diradò.
Interessante è leggere anche qualche nota dal volume "Le streghe in Valtellina" di Vittorio Soinetti (Sondrio, 1903): "Nella sola Diocesi di Como a cui ab antico appartenne giuridicamente la Valtellina, e a cui ecclesiasticamente è ancora soggetta, il numero dei processati di stregheria, secondo Bartolomeo Spina, superava spesso il mille ogni anno e più di cento si abbruciavano. Ed è forse in questa Diocesi, forse anche nella Valtellina stessa che incominciarono prima che altrove i veri processi contro la malefica setta delle streghe, se vogliamo prestar fede a ciò che riferisce fra Bernardo Rategno nel suo manuale De Strigiis, — che fa seguito al suo trattato — Lucerna Inquisitorum, — il qual frate fu inquisitore a Como nel 1505, e passò… nefasto a stendere processi nella valle. Ecco che cosa scrive il nostro frate: «La predetta setta delle streghe cominciò a pullulare solamente da centocinquant'anni in qua, come risulta dagli antichi processi degli Inquisitori, che sono negli Archivi della nostra Inquisizione di Como». Quindi verso il 1350.
Sicché più di trecentocinquant'anni durò nella Valtellina la persecuzione contro la così detta pestifera setta delle streghe, perchè abbiamo nell'Archivio notarile di Sondrio il documento di un processo intentato contro un certo Valento ohm Romerio Romeggione di San Rocco, decapitato in Tirano come stregone confesso nel mese di marzo dell'anno 1703, e più di quattrocento se il processo contro Maddalena Lazzari avvenne, come mi fu riferito, a Bormio nel 1796."
Ma dove
visse, dove e come morì l’ultima strega di Valtellina?
Stando a quanto racconta una leggenda (riportata a Giambattista Marchesi nel  volume "In Valtellina, costumi, leggende e tradizioni", Clausen, Palermo-Torino, 1898, pg. 421), la storia delle streghe di Valtellina
non si concluse con i bagliori di un ultimo sinistro rogo, ma in maniera
meno eclatante e più malinconica. L’ultima strega non fu
bruciata, ma bandita, indotta a lasciare il consorzio degli uomini,
a raggiungere gli esseri malefici simili a lei, che, si credeva, popolavano
i boschi, assumendo le forme di lupi, capre demoniache (la “cavra
bèsüla”), volpi, gatti selvatici, perfino orsi.
volume "In Valtellina, costumi, leggende e tradizioni", Clausen, Palermo-Torino, 1898, pg. 421), la storia delle streghe di Valtellina
non si concluse con i bagliori di un ultimo sinistro rogo, ma in maniera
meno eclatante e più malinconica. L’ultima strega non fu
bruciata, ma bandita, indotta a lasciare il consorzio degli uomini,
a raggiungere gli esseri malefici simili a lei, che, si credeva, popolavano
i boschi, assumendo le forme di lupi, capre demoniache (la “cavra
bèsüla”), volpi, gatti selvatici, perfino orsi.
Tutto ciò accadde in quel di Ardenno, il primo paese, ad est,
del Terziere della bassa Valtellina (oggi mandamento di Morbegno), il
cui nome, forse, deriva dal verbo “ardere”. Curioso: un
paese che conserva, nel nome, l’immagine di un fuoco che arde
fu la cornice della sorte dell’ultima strega di Valtellina, che
però non fu arsa, non fu uccisa dal calore che consuma, ma condannata
a morire nei boschi, a soccombere ad terribile gelo invernale, che non
risparmia chi non abbia un ricovero caldo.
Ecco
come andarono le cose. Siamo a Piazzalunga, piccola frazione a monte
di Ardenno, denominata così per il bel corridoio di prati sul
quale è collocata, in una posizione climaticamente e panoramicamente
assai felice (di qui si domina, con lo sguardo, la sezione occidentale
della media Valtellina). Il periodo in cuiaccaddero i fatti è
indeterminato, ma possiamo supporre che fosse il Settecento inoltrato.
A Piazzalunga viveva una donna singolare, che, fin da giovane, aveva
mostrato tante stranezze, nel carattere e nel comportamento, da non
aver trovato nessuno che la prendesse come moglie. Forse non aveva mai
neppure cercato un marito, e sicuramente non aveva mai mostrato quella
cura di sé che è tratto comune di tutte le donne, anche
di più umile condizione. Non aveva famiglia, viveva sola. Appariva
trasandata, scarmigliata, e, con il passare degli anni, il suo aspetto
si era fatto più sinistro, il corpo più ossuto e curvo,
il volto più smunto, lo sguardo più perso in chissà
quali visioni. Viveva di espedienti: passava intere giornate a raccogliere
erbe nei boschi, coltivava un piccolo orto, accoglieva i piccoli che,
senza troppo dare nell’occhio, qualche mano generosa le offriva.

Piazzalunga
Scendeva, spesso, ad Ardenno, lungo la bella mulattiera che da Piazzalunga
conduce al poggio di SanLucio, e qui raggranellava anche qualche soldo
vendendo pozioni ed erbe che, a suo dire, avevano effetti prodigiosi, suscitavano
amori, attizzavano passioni, rinvigorivano le membra stanche. Leggeva
anche la mano, indovinava il futuro, prediceva eventi belli ed eventi
brutti.
Suscitava, a Piazzalunga ed Ardenno, reazioni contrastanti: molti la
temevano, alcuni credevano nelle sue capacità magiche e speravano
di trarne vantaggio, molti, però, anche, si prendevano gioco
di lei, approfittando della sua solitudine e di quella parvenza tutto
sommato inoffensiva ed inerme: veniva,  talvolta, dileggiata, insolentita,
qualche ragazzo le scagliava contro un sasso, un piccolo bastone, un
osso. Lei si limitata a farsi schermo con le mani ed a borbottare qualcosa,
forse in una lingua sconosciuta, che sembrava un po’ lamento,
un po’ maledizione.
talvolta, dileggiata, insolentita,
qualche ragazzo le scagliava contro un sasso, un piccolo bastone, un
osso. Lei si limitata a farsi schermo con le mani ed a borbottare qualcosa,
forse in una lingua sconosciuta, che sembrava un po’ lamento,
un po’ maledizione.
Insomma, si meritò l’appellativo di “strìa”,
strega, in un periodo nel quale di streghe si parlavano sempre meno,
e con sempre minore paura: bambini e ragazzi, quando la vedevano scendere
con quello sguardo un po’ sbieco e quel buffo canestro pieno di
erbe, gridavano, ridendo e fingendo una paura tutta simulata: “Vìtela,
la strìa, vìtela, la stria”, cioè “Guardala,
la strega, guardala, la strega!”, o anche: “strìa,
strìa, striùna, ciàpum, se te se buna”, cioè
“Strega, strega, stregona, prendimi, se sei capace”. In realtà era solo una pallida ombra, un'immagine sbiadita di quelle che dovettero essere le ben più determinate e malvage megere del secolo precedente, il cui ricordo era consegnato alla tenace memoria degli avi: i vecchi ne parlavano, la sera, nelle stalle, quando si "faceva filò" e si narrava dei folleti dispettosi che slegavano le mucche.
Ma la povera strega fuori tempo massimo non faceva realmente paura a nessuno, anzi, era
lei ad avere  paura di quel marchio. Si isolò, quindi, sempre di più,
non mise più piede in chiesa, in tempi nei quali un comportamento
del genere significava porsi al di fuori della comunità. Il parroco,
che non credeva veramente nelle sue capacità malefiche, ma voleva
stroncare quel segreto ricorrere di alcuni suoi parrocchiani alle arti
della superstizione, condannate dalla Chiesa (era un peccato assai grave,
un peccato mortale), decise
di approfittarne per farla finita con la strega di Piazzalunga, e la
scomunicò solennemente. La scomunica rappresentava non solo l’allontanamento
dalla comunità della Chiesa, ma anche quello dalla comunità
civile. Fu così che la “strìa” lasciò
Piazzalunga, ritirandosi nei bei boschi di castagni a monte del paese.
paura di quel marchio. Si isolò, quindi, sempre di più,
non mise più piede in chiesa, in tempi nei quali un comportamento
del genere significava porsi al di fuori della comunità. Il parroco,
che non credeva veramente nelle sue capacità malefiche, ma voleva
stroncare quel segreto ricorrere di alcuni suoi parrocchiani alle arti
della superstizione, condannate dalla Chiesa (era un peccato assai grave,
un peccato mortale), decise
di approfittarne per farla finita con la strega di Piazzalunga, e la
scomunicò solennemente. La scomunica rappresentava non solo l’allontanamento
dalla comunità della Chiesa, ma anche quello dalla comunità
civile. Fu così che la “strìa” lasciò
Piazzalunga, ritirandosi nei bei boschi di castagni a monte del paese.
Non si fece più vedere, non se ne seppe più nulla. Di
lei rimase solo la memoria nei moniti che mamme e nonne, per assicurarsi
il pronto ritorno di figli e nipoti sul far della sera, rivolgevano
loro: “Sta atenta che quant che ‘l suna l’Ave Maria,
saltà fö la strìa”, cioè “Stai
attento che quando suona l’Ave Maria – cioè dopo
le sei di sera – viene fuori la strega”, e la strega per
antonomasia era sempre lei, la strega di Piazzalunga. Venne, infine,
trovata,  qualche anno dopo, morta, probabilmente stroncata dai rigori
di un inverno, nel cuore di un bosco. Di lei non si sa neppure dove
fu sepolta. Rimase solo l'eco, nel lamento del vento d'inverno, fra
le fronde spoglie. Era l’ultima strega di Valtellina: terminò
con lei, senza bagliori, senza clamori, la storia delle streghe della
valle.
qualche anno dopo, morta, probabilmente stroncata dai rigori
di un inverno, nel cuore di un bosco. Di lei non si sa neppure dove
fu sepolta. Rimase solo l'eco, nel lamento del vento d'inverno, fra
le fronde spoglie. Era l’ultima strega di Valtellina: terminò
con lei, senza bagliori, senza clamori, la storia delle streghe della
valle.
Questa leggenda riflette un qualche fondo storico? Non ci sono documenti al riguardo. Anche il "crap de la stréga", un grande masso di forma piatta che si incontra sul sentiero (che oggi sopravvive a stento all'assalto del caso vegetale) che corre sul crinale che separa val Venduno (Vendùn) e Val Valéna, nella media montagna sopra Ardenno, è probabilmente l'eco dell'immaginario popolare più che si effettivi episodi di persecuzione di presunte streghe. Questo masso è chiamato anche "sasùn"; secondo alcuni il vero crap de la strìa si trova nel cuore della bassa Val Venduno, ed è uno spuntone di roccia sul suo versante orientale.
Si racconta che sul masso detto anche "sasùn" sia impresso il segno della zoccola calzata da una tremenda strega, che aveva eletto quei luoghi a sua dimora ed insidiava i viandanti solitari. Una variante della leggenda parla del tentativo, inutile, della strega di far rotolare il masso sulla sottostante frazione di Ca' Maroli, in località Pèsc. Un masso legato ad un'analoga leggenda, e chiamato "balùn", si trova sul crinale del dosso che separa la Val Valena dalla Val Venduno, ad ovest di gaggio e più o meno alla medesima altezza di questa frazione.
Questa non è, comunque, l'unica storia di donne strane, bizzarre, selvatiche.
In quel di Ardenno molti anziani conoscono, magari con diverse 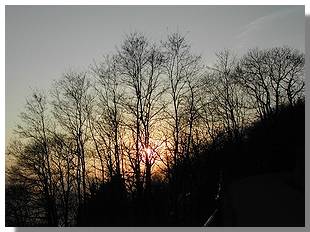 varianti,
la storia della “màta selvàdega”, o “màta
salvàdega”, cioè della matta selvatica, donna terribile
che viveva sola, spauracchio dei bambini disobbedienti, che, a detta
delle nonne, amava rapire e bollire in un gran calderone. Nella
frazione Masino assicurano che la sua dimora era un enorme masso nel
mezzo del torrente omonimo, che scende dalla Val Màsino. Altri
sostenevano che invece quel masso fosse il nascondiglio in cui una banda
di falsari nascondeva il denaro falso, come leggiamo nel volume di G. Marchesi "In Valtellina - Costumi, leggende e tradizioni", pg. 422: la leggenda vuole poi che le anime di questi disonesti siano state condannate a dimorare in etermo in questo masso, come anime di "confinati".
varianti,
la storia della “màta selvàdega”, o “màta
salvàdega”, cioè della matta selvatica, donna terribile
che viveva sola, spauracchio dei bambini disobbedienti, che, a detta
delle nonne, amava rapire e bollire in un gran calderone. Nella
frazione Masino assicurano che la sua dimora era un enorme masso nel
mezzo del torrente omonimo, che scende dalla Val Màsino. Altri
sostenevano che invece quel masso fosse il nascondiglio in cui una banda
di falsari nascondeva il denaro falso, come leggiamo nel volume di G. Marchesi "In Valtellina - Costumi, leggende e tradizioni", pg. 422: la leggenda vuole poi che le anime di questi disonesti siano state condannate a dimorare in etermo in questo masso, come anime di "confinati".
Sempre a Masino viveva un tale che passò la sua infanzia nel
terrore per questa donna terribile: quante volte, dopo aver combinato
qualche marachella, era stato preso dalla paura che la màta salvadega venisse, nel cuore della notte, e se lo portasse via! Poi, man mano
che la sua età e la sua forza crescevano, la paura diminuì,
ma gli rimase dentro un senso di risentimento e di fastidio per questa
figurache aveva tormentato come un’ombra minacciosa la sua infanzia.
Decise, allora, di toglierla di mezzo. Si caricò sulle spalle
una brenta di vino e si avviò verso il grande masso che la temibile
donna aveva scelto come dimora.
Quando la vide, ne ebbe più ribrezzo che paura, ma lo vinse e,
fingendo grande affabilità, le chiese se volesse bere. Questa,
dopo averlo guardato con quegli occhietti spiritati dai quali traspariva
tutta la sua follia, per tutta risposta si mise a sghignazzare, e spiccò
un balzo prodigioso. Per un attimo il nostro  temette di vedersela piombare
addosso, ma la matta si infilò proprio dentro la brenta (non
era un donnone!) e cominciò avidamente a bersi quel buon vino.
L’uomo, allora, colse al volo l’occasione e spinse la brenta
nel torrente. Sparirono, così, nei gorghi impetuosi del torrente
Masino, brenta vino e vecchia.
temette di vedersela piombare
addosso, ma la matta si infilò proprio dentro la brenta (non
era un donnone!) e cominciò avidamente a bersi quel buon vino.
L’uomo, allora, colse al volo l’occasione e spinse la brenta
nel torrente. Sparirono, così, nei gorghi impetuosi del torrente
Masino, brenta vino e vecchia.
Rimasero,
all’anonimo audace, l’orgoglio per aver fatto giustizia,
ma anche il rimpianto per il vino perso e la brenta sprecata.
Alla "mata salvadega" fa da contraltare la saggezza di una donna che sa riscattarsi dalla brutta china nella quale rischia di scivolare per le lusinghe di due giovani e per l'amore per il ballo. E' il tema di una storiella edificante, simile a molte altre, varianti di un unico tema, che ha come teatro la storica mulattiera che da San Lucio porta a Piazzalunga. Ne
è protagonista una tale, soprannominata "la Pevéta",
appassionata amante del ballo. Costei si trovò a passare per
questo cincet mentre scendeva da Biolo per recarsi a Gaggio, per partecipare
ad una serata danzante. Nell'immaginario religioso tradizionale, però,
il ballo è parente prossimo della tentazione e del peccato. La
giovane donna, infatti, non se ne scendeva da Piazzalunga sola, ma era accompagnata da due avvenenti giovanotti. Ma, proprio transitando davanti
alla figura del Cristo sofferente sulla croce, ebbe come un sussulto
nella coscienza, comprese la leggerezza del suo comportamento e se ne
pentì. Chiese, quindi, ai due di attendenderla un attimo e si
inoltrò nella vicina  selva, a monte del cincet, nascondendosi
nell'incavo di un grande castagno. I due la attesero invano, ed alla
fine, scrollando le spalle, proseguirono soli. La donna, invece, tornò
sui suoi passi, ripromettendosi, per il futuro, di tenere un comportamento
più prudente ed assennato.
selva, a monte del cincet, nascondendosi
nell'incavo di un grande castagno. I due la attesero invano, ed alla
fine, scrollando le spalle, proseguirono soli. La donna, invece, tornò
sui suoi passi, ripromettendosi, per il futuro, di tenere un comportamento
più prudente ed assennato.
Perché non si pensi che Ardenno sia solo terra di leggende oscure o sbalzate sull'eterno tema delle molteplici espressioni ed insidie del male, citiamo poche righe dal bel volume “In Valtellina - Colori di leggende e tradizioni”, (Sondrio, Ramponi, 1950) di Rina Lini Lombardini: "Anticamente, anche in Ardenno uomini e donne, seduti di sera sui muriccoli delle loro case, intonavano durante il tempo dei fieni bei canti d'amore, rimanendo all'aperto fino a tarda sera".
Ma la chiusura di questa rapida carrellata deve essere riservata a lui, l'animale fantastico ed indefinito per eccellenza, il Gigiàt. Sì, è vero, la sua patria d'elezione è la Val Masino, ma, stando a quanto scrive Aurelio Garobbio, uno dei maggiori studiosi dell’universo immaginario dell’arco alpino, nella bella raccolta “Montagne e Valli incantate”, (Rocca San Casciano, Cappelli, 1963, pp. 151-152), quasto mitico animale frequentava anche il territorio di Ardenno, e, per la precisione, i vigneti ardennesi. Ma riportiamo per intero il testo del Garobbio:
 "“In val Masino vive il Gigiat. Selvaggio ed inquieto passa da un alpeggio all'altro lottando con i torelli, balza sulle giogaie con i camosci e si sente anche lui un camoscio, irrompe nelle danze delle marmotte e le afferra costringendole a ballare con lui, salta nelle fratte fra i caprioli, s'arrampica con gli scoiattoli sui pini ed appeso ai rami dondola nell'aria. Qualcuno gli ha scorto le corna ritorte del capro nascoste tra i lunghi capelli, qualcuno ha veduto impronte di zoccoli dove è passato. Se apre la porta della baita e mette dentro il capo, la sua risata rischiara l'aria; se beve alla fonte, l'acqua diventa più copiosa. Uomo o bestia, il Gigiat è incontrastato signore tra il Badile ed il Cengalo, il Torrone ed il Disgrazia.
"“In val Masino vive il Gigiat. Selvaggio ed inquieto passa da un alpeggio all'altro lottando con i torelli, balza sulle giogaie con i camosci e si sente anche lui un camoscio, irrompe nelle danze delle marmotte e le afferra costringendole a ballare con lui, salta nelle fratte fra i caprioli, s'arrampica con gli scoiattoli sui pini ed appeso ai rami dondola nell'aria. Qualcuno gli ha scorto le corna ritorte del capro nascoste tra i lunghi capelli, qualcuno ha veduto impronte di zoccoli dove è passato. Se apre la porta della baita e mette dentro il capo, la sua risata rischiara l'aria; se beve alla fonte, l'acqua diventa più copiosa. Uomo o bestia, il Gigiat è incontrastato signore tra il Badile ed il Cengalo, il Torrone ed il Disgrazia.
D'autunno passa tra i castagneti e urlando divalla a piroette: ricci e foglie diventati di bronzo gli s'attaccano al petto ed alla schiena. Di primavera sceglie un alpeggio per farsi tosare il lungo vello ricciuto prima di risalire sulle cime. Per il Gigiat si lascia sulla lista di prato segato un po' d'erba e prima di scaricare i monti si deposita del fieno sulla porta delle baite perché quando la neve tutto copre egli lo trovi. Per lui le donne nascondono nei boschi cacio, castagne, noci.
C'è chi l'ha visto metà uomo e metà capro sfrecciare fra gli alberi e scomparire come se inghiottito dalla scagliosa. corteccia di un cembro; c'è chi l'ha udito fra i vigneti d'Ardenno, quando i grappoli si tingono, suonare con lo zufolo ed il crosciare della cascata si intonava a quella melodia come il fremito delle selve ed il battere del cuore. Perché il Gigiat è simbolo della vita che si rinnova e dell'eterna giovinezza che sta sui monti e dai monti scende con i fiumi ad allietare il mondo.”

Vigneti sopra Morano
CARTA DEL PAESE sulla base della Swisstopo, che ne detiene il Copyright. Ho aggiunto alla carta alcuni toponimi ed una traccia rossa continua (carrozzabili, piste) o puntinata (mulattiere, sentieri). Apri qui la carta on-line.

Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas La riproduzione della pagina o di sue parti è consentita previa indicazione della fonte e dell'autore (Massimo Dei Cas, www.paesidivaltellina.it)
Escursioni e camminate (consigli ed indicazioni; I miei canali su YouTube: paesi e campane, rifugi e vette, passi e poesie, poesie, musica) |
|||||||
Storia, tradizioni e leggende |
|||||||
Immagini, suoni e parole |
|||||||
Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas Designed by David Kohout
